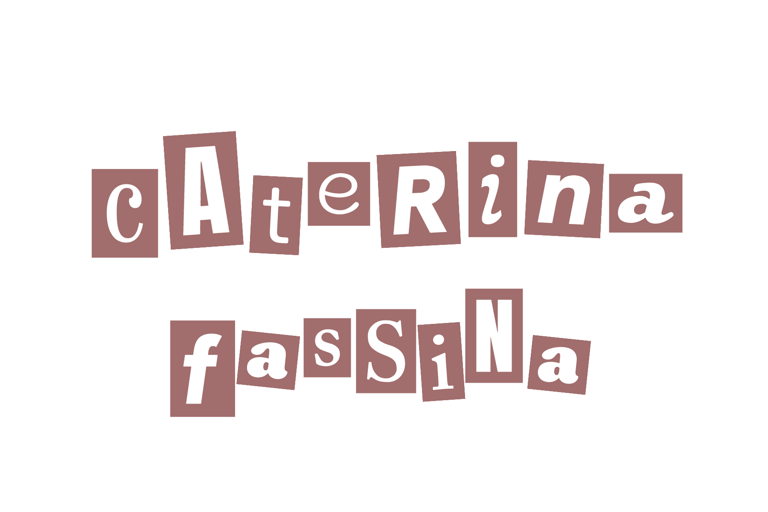Elsa Schiaparelli: la moda oltraggiosa
La storia della stilista Elsa Schiaparelli che riuscì a intrecciare moda, arte e militanza contro il fascismo che invade l'Europa negli anni Trenta.
Caterina Fassina
11/25/202422 min read
È molto difficile lasciare andare, non serbare rancore, perdonare ma non dimenticare. Convivere con la consapevolezza dei torti subiti, sentirli mentre ti buttano giù, percepire che il loro ricordo è una gabbia da cui è quasi impossibile uscire. Si cerca una vita di riscatto, una sorta di vendetta verso chi ci ha commesso quei torti. Così viviamo per loro e mai per noi stessi. La nostra protagonista di oggi ribalta questa prospettiva e vive sì per gli altri, ma mai per chi la ferisce. Spezza il peso dei torti subiti facendo sentire ognuno importante, facendo del suo meglio per portare la bellezza nel mondo. È una lavoratrice indefessa, un’innovatrice, una madre single che all’inizio della sua carriera si riduce a non mangiare pur di garantire a sua figlia la migliore vita possibile. È un’imprenditrice che si prende a cuore il benessere dei suoi dipendenti. È una donna che apre la sua casa ai rifugiati durante la Seconda Guerra Mondiale e che reperisce personalmente fondi e medicinali per i civili coinvolti nella devastazione della guerra. Rischia tutto, persino l’oblio culturale, pronunciandosi contro il fascismo sin dal 1922. La nostra protagonista di oggi è Elsa Schiaparelli.
Elsa nasce il 10 settembre 1890 a Palazzo Corsini a Roma, un gioiello ai piedi del Gianicolo, incastonato tra Trastevere e il Vaticano. Suo padre Celestino, professore di Lingua e letteratura araba alla Sapienza, avrebbe voluto un maschio dopo la primogenita Beatrice. Con grande rammarico nasce invece una seconda bambina. Celestino e sua moglie Giuseppa sono talmente delusi che non le danno nemmeno un nome. Quando dieci giorni dopo si recano a San Pietro per farla battezzare si rendono conto di non avere un nome pronto. La chiamano Elsa come la sua balia. Sono due genitori poco interessati alla bambina.
Oltre a insegnare, Celestino è il primo bibliotecario dell’Accademia Nazionale dei Lincei, che si trova di fronte a Palazzo Corsini. L’Accademia dei Lincei è una delle più, se non la più, importante organizzazione internazionale che promuove le arti umanistiche. Celestino aveva ottenuto il ruolo grazie alla sua conoscenza del mondo arabo e questo gli aveva permesso di vivere nelle stanze di Palazzo Corsini. Celestino è anche grande amico del Re Vittorio Emanuele II (quello che se la faceva con Virginia Oldoini) con cui condivide la passione per le monete d’epoca.
Suo fratello Ernesto Schiaparelli, zio di Elsa, è senatore, ma soprattutto è l’egittologo che scopre la tomba di Nefertiti e colui a cui si devono gli accordi che hanno portato alla fondazione del Museo Egizio di Torino.
La madre Giuseppa proviene invece da una famiglia nobile napoletana. Suo padre era un diplomatico presso l’ambasciata di Malta e lei è famosa, così come sua sorella, per essere molto bella. Dà molta importanza all’aspetto fisico ed Elsa è molto carina, ma la famiglia pensa che lo sia meno di sua sorella maggiore Beatrice. Elsa ne soffre molto durante l’infanzia, tanto che si pianta nel naso e nelle orecchie dei semi nell’illusione di diventare bella una volta fioriti. Inutile dire che finisce dal medico con una certa urgenza.
Quando Elsa raggiunge l’età scolare, Celestino la spedisce in un collegio cattolico in Svizzera. Qui viene trattata talmente male che rinnega il cattolicesimo e si trasferisce in un collegio protestante, le cui regole però sono molto più severe di quelle del convento cattolico. L’esperienza elvetica di Elsa si rivela fallimentare e i genitori si convincono a farla tornare a Roma e a mandarla a scuola con la sorella, scelta che però non fa altro che moltiplicare i paragoni sulla bellezza delle due.
La piccola Elsa nasce e cresce quindi in una famiglia benestante di intellettuali in vista, ma i suoi genitori non passano molto tempo con lei. Le poche volte che le parla, la madre le fa presente che sua sorella è più bella, che Elsa ha gli occhi troppo grandi ed è troppo magra. Il continuo paragone con Beatrice non permette alle due di sviluppare un legame sincero ed Elsa avrà sempre problemi ad accettare la sua fisicità.
Le piacciono molto i suoi zii; la sorella di sua madre che vive in Egitto e le spedisce manufatti africani e anche Giovanni, altro fratello di suo padre e astronomo, che le fa guardare il cielo stellato con il telescopio. Elsa parla con Giovanni delle sue difficoltà ad accettarsi: è l’unico in cui confida. Gli confessa di odiare in particolare una cascata di nei sulla guancia sinistra. Lui la guarda e, al posto che confermare ciò che le dicono i suoi genitori, le fa notare che i nei sono sette e sono nella stessa posizione del Grande Carro. Giovanni la convince di essere fortunata ad avere una caratteristica così rara e preziosa. Probabilmente anche per questo Elsa nutrirà una grandissima passione per le stelle, elementi grafici e concettuali che cercherà di incorporare più avanti nelle sue creazioni.
Grazie all’importanza della cultura in casa ma anche a causa della sua solitudine, Elsa passa ore a studiare filosofia antica e scrive una marea di poesie poco convenzionali. Studia filosofia in Sapienza, ma la sua vena creativa inizia a delinearsi. Alcune sue poesie vengono anche pubblicate grazie all’aiuto di suo zio Giovanni e riscuotono molto successo: lei ha ormai 21 anni, ma la sua famiglia si rifiuta di appoggiarla. La maggioranza dei giornali scrivono recensioni positive, definendo la raccolta molto elegante. La raccolta viene descritta come “profondamente umana ed essenzialmente emozionante.”
I genitori pensano però che le vite degli artisti siano solo portatrici di scandalo e la spediscono in un convento svizzero, dove passa 99 giorni durante i quali Elsa si ribella al punto di farsi scomunicare. Una sua amica riesce a convincere Celestino a recarsi in Svizzera per verificare le condizioni della figlia. Quando arriva, lo informano che Elsa porta avanti da giorni uno sciopero della fame e Celestino si convince a riportarla a casa.
I genitori iniziano a cercarle un marito, nella speranza di farle mettere la testa a posto, ma lei li rifiuta tutti. Si innamora di Pino, un ragazzo napoletano che le regala mazzi di rose e che però è povero e viene cacciato dai coniugi Schiaparelli. Il cuore di Elsa viene spezzato e i suoi genitori le danno un motivo in più per odiarli. È a questo punto che Elsa decide di andarsene. Nella sua biografia scrive: “Avevo un pensiero fisso in testa: salvarmi dalla monotonia della vita di salotto e dall’ipocrisia borghese.”
Nel 1913 riesce a convincere il padre a mandarla a Londra per aiutare gli orfani. Quando parte, giura di non tornare più in Italia, dove si sente soffocare. Durante il viaggio si ferma a Parigi per dieci giorni, dove sperimenta una realtà completamente diversa e molto più all’avanguardia rispetto a Roma. A Parigi si respirano modernità e futuro. Viene invitata in un party casalingo per cui però non ha alcun vestito adatto. Non sa cucire e quindi mette insieme il vestito usando solo delle spille. Compra della stoffa e confeziona una tuta blu alla zuava con una cintura gialla che le cinge la vita sottile. È il suo primo passo d’indipendenza.
A Londra inizia a farsi chiamare Schiap e si innamora William de Wendt de Kerlor, un trentenne esperto di esoterismo, di certo non molto ricco, ma con il titolo nobile di Conte. Quando i genitori vengono a conoscenza della relazione, si precipitano a Londra per impedire alla figlia di sposarlo, ma ormai è tardi. Elsa se l’è già sposato. È il 1914. Quando poco dopo inizia la guerra, William pubblica l’oroscopo della guerra. Fa previsioni astrologiche sull’andamento del conflitto. Nel 1915 viene espulso dall’Inghilterra perché predire il futuro era illegale. I due si trasferiscono a Nizza e il matrimonio inizia a scricchiolare. Elsa passa molto tempo al casinò di Montecarlo tanto da diventare un habitué. Spende tutti i loro soldi in un anno, risparmiando però la sua dote, che i due utilizzano per trasferirsi a New York. Vivono al Greenwich Village e qui inizia a frequentare i dadaisti, soprattutto i coniugi Picabia, Man Ray e Duchamp. William apre uno studio dove performa rituali psichici che hanno un discreto successo a New York.
Nel 1919 Elsa si rende conto che suo marito non ha empatia, è spesso violento, un manipolatore. Vede ormai tutti i suoi trucchi, li conosce a memoria. È anche infastidita dalla sua mediocrità. In questo periodo suo padre Celestino muore ed Elsa si rende conto di aver sbagliato a sposare William. Quando però stanno per divorziare, Elsa si accorge di essere incinta. Nel giugno del 1920 i due accolgono la loro primogenita Maria Luisa, soprannominata affettuosamente Gogo. Nessuno dei due però vuole continuare il matrimonio e si separano. Entrambi non hanno i soldi per crescere una bambina, ma è Elsa a doversene occupare. È sola a New York senza soldi con una bambina piccola.
Elsa si rifiuta categoricamente di chiedere soldi all’ex marito o di accettare quelli della sua famiglia, che avrebbe accolto con gioia sia lei che la bambina a Roma. Elsa non vuole però rinunciare alla sua libertà né far passare a sua figlia l’infanzia che ha subito lei.
“Molti uomini ammirano le donne forti ma non le amano. Alcune donne riescono ad essere forti e dolci allo stesso tempo, ma la maggior parte di quelle che hanno deciso di andare avanti per la loro strada a testa alta ha perso la felicità.”
Per cercare lavoro lascia la piccola Gogo per ore da sola, spesso sulle scale antincendio degli hotel in modo da evitare che si accorgessero della presenza della bambina o che lei facesse troppo rumore. Elsa vede la bambina più come un peso che come una benedizione. Gaby Picabia si offre di prendere Gogo, di modo che passasse tempo sicura e serena insieme ai suoi quattro figli. Gaby offre anche un lavoro a Elsa come intermediaria di pezzi di alta moda. Elsa avrebbe dovuto venderli a compratori statunitensi. Iniziano a vivere insieme e a frequentare spesso il circolo degli artisti d’avanguardia, in particolare i membri Dada.
A un certo punto però il lavoro per Gaby si esaurisce. Elsa deve tapparsi il naso e chiedere un piccolo stipendio mensile alla madre, che però è felice di aiutarla e non chiede niente in cambio. Riesce così a mandare Gogo in un asilo nel Connecticut.
Elsa fa lavoretti qua e là, quelli che capitano, ma sono impieghi instabili e mai sicuri. Nel frattempo incontra il baritono italiano Mario Lorenzi, con cui ha molto in comune, separazione compresa. I due intraprendono una relazione che causa parecchio scandalo dato che entrambi sono ancora formalmente sposati. William decide di avviare il divorzio e chiede l’affidamento esclusivo di Gogo, che poco dopo prende la poliomielite. Così Elsa scopre che la figlia in Connecticut vive in un ambiente sporco dove i bambini vengono trattati male. Elsa deve pagarle le cure; Lorenzi l’aiuta, ma poco dopo muore anche a causa di una meningite. È il 1922 ed Elsa è stremata, povera, senzatetto e ha una figlia che ha bisogno di urgenti e costose cure dato che non riesce più a muovere le gambe. Non scordiamoci nemmeno il cuore spezzato per la morte di Lorenzi. Elsa riesce sempre a pagare per i trattamenti e per i collegi della figlia, ma è costretta a lavorare molto e non riesce a passare tempo con lei. È in questo periodo che la figlia inizia a essere soprannominata Gogo proprio perché, quando la madre deve andare via, lei le risponde “go, go”, ovvero “vai, vai”.
Elsa nota che la situazione sfugge al suo controllo e sceglie di tornare in Europa. Dà alla figlia il suo cognome in modo da avere più chances di vincere la custodia e partono per Parigi. Riprende la nazionalità italiana, che le permette di vivere in Francia. Manda Gogo a vivere insieme a Gaby Picabia, anche lei tornata a Parigi. È sempre Gaby che trova anche un medico che segua Gogo. Finalmente la bambina vive quotidianamente una famiglia stabile in cui crescere serena. Elsa nel frattempo vive in un appartamento insieme a un’amica anche lei separata.
Inizia anche a lavorare nel mondo dell’antiquariato come intermediaria per la vendita di oggetti d’arte. Grazie al suo nuovo lavoro e frequentando i caffè di Parigi, Elsa conosce i personaggi di spicco dell’epoca, tra cui Nancy Cunard, di cui abbiamo raccontato la vita nel terzo episodio. Man Ray le presenta anche Coco Chanel, Igor Stravinsky (con cui Coco ha una relazione) e André Gide nel locale La Boeuf sur le Toit. Iniziando a frequentare gli artisti del tempo, Elsa annovera tra i suoi clienti personaggi illustri come i reali inglesi e Jean Cocteau.
Sempre nell’estate del 1922 incontra grazie a Gaby lo stilista Paul Poiret. Oggi la maison di Poiret non è conosciuta, ma all’epoca Poiret era come Giorgio Armani. Tutti sapevano chi fosse ed era considerato colui che aveva mandato in pensione la moda della Belle Époque e iniziato un percorso verso il modernismo. Poiret però dopo la Prima Guerra Mondiale viene surclassato da Coco Chanel, che immette nel mercato dei design più sportivi a un costo più contenuto.
Poiret aveva assunto Gaby Picabia come organizzatrice dei suoi eventi e delle sue lussuose feste private. Gaby però non possedeva alcun vestito adatto e chiede a Elsa di disegnarle qualcosa che lasci il segno. Elsa confeziona un vestito che colpisce Poiret perché i suoi design sono molto bizzarri, ma funzionano. Poiret si prende a cuore Elsa e le regala un cappotto che lei non si può permettere. La vizia parecchio dato che le regala un intero guardaroba. Poiret diventa di fatto il suo mentore e il suo trampolino di lancio nel mondo della moda: spesso le creazioni dei due vengono paragonate. Sicuramente Elsa è colpita dalla sua generosità e si sente apprezzata forse per la prima volta.
Elsa inizia quindi il suo percorso all’interno della moda parigina fino a diventare stilista per Maison Lambal nel 1925. Due anni più tardi, dopo parecchi tentativi, inizia a confezionare dei pullover in casa sua perché non le piacciono i vestiti sportivi che confeziona la Maison di Coco Chanel, anche se hanno molto successo. Aveva visto un pullover cucito da Mike, un’immigrata armena il cui nome completo è Aroosiaf Mikaelian. Spesso chi proveniva dall’Asia apriva a Parigi dei piccoli atelier di tessuti lavorati artigianalmente. Mike utilizza la tecnica trompe-l’oeil, che consiste nel simulare la terza dimensione su una superficie in realtà bidimensionale. I primi pullover di Elsa sono neri e bianchi, semplici ed eterni, ma non sono considerati alta moda, haute couture. I magazzini statunitensi Strauss però li acquistano per rivenderli ed Elsa diventa un punto di riferimento per il maglione. Prima di lei il pullover era considerato per lo più un indumento da lavoro, un oggetto pratico per scaldare le classi meno abbienti costrette a lavorare in campagna. Elsa disegna i modelli che poi passa a Mike che li confeziona. Elsa disegna il maglione a doppio nodo realizzato sempre in trompe-l’oeil a completare uno scollo a V. Il maglione ha talmente tanto successo che a dicembre del 1927 finisce direttamente su Vogue e viene venduto in Europa e negli Stati Uniti.
Certamente le sue connessioni famigliari aiutano la sua scalata al successo come stilista. Elsa non fa la stessa fatica che deve sopportare Coco Chanel, che ha invece delle origini molto più umili. Inoltre, proprio grazie alla figura di Chanel, una vera e propria pioniera, Elsa viene considerata una stilista e non una semplice sarta. Forse per questo motivo Chanel non nutre parecchia simpatia per Elsa, come vedremo più avanti.
Elsa ha un ritorno economico inaspettato ed espande l’attività. La salute di Gogo migliora molto, tanto da riuscire a fare brevi passeggiate. Elsa la iscrive in un collegio svizzero con la speranza che riceva la migliore istruzione e che questa la renda economicamente indipendente e libera. Gogo però non la pensa nello stesso modo e si sente abbandonata, anche perché la madre non riesce ad andare a visitarla spesso. Elsa vuole molto bene a Gogo; la bambina è il motivo per cui si ammazza di lavoro, ma quando si è piccoli non si capisce il mondo degli adulti.
Elsa diventa presto un nome nel mondo della moda. Ha un approccio molto avanguardista che sicuramente è influenzato dai circoli di artisti che frequenta giornalmente a Parigi. I motivi delle sue creazioni derivano dall’astrattismo, dal futurismo, dal dadaismo e dal surrealismo. Disegna ossa umane sui maglioni (avete presente quelle felpe con disegnati sopra gli scheletri? Ecco, invenzione di Schiaparelli). Vuole un abbigliamento sportivo che non rinunci a un tocco di esclusività. Si colloca a metà tra il casual di Chanel e la moda couture più elaborata. Disegna costumi, pigiami, oltre ai pullover ovviamente. L’idea è di adattarsi alla nuova donna che esce dalla Prima Guerra Mondiale e dalla prima ondata di femminismo, donna incarnata dalla stessa Elsa. Una donna dinamica che vuole lavorare, essere indipendente dal controllo maschile, vuole studiare, madre se capita, ma sicuramente una professionista.
Elsa continua a incassare successi ed è una lavoratrice instancabile: si occupa di tutto, anche della gestione economica e imprenditoriale della maison, cosa non comune all’epoca. Le sue collezioni vengono fotografate dai maggiori fotografi di moda del tempo: Horst, Hoyningen-Huene, che sono felici di lavorare con le sue bicromie, i colori accesi e le geometrie. La Maison Schiaparelli riesce persino a influenzare l’arte modernista negli Stati Uniti, confermando l’idea che la moda sia un’arte a tutti gli effetti.
È un periodo di successi personali e professionali che la soddisfano profondamente e la ripagano di tanti sacrifici. Con i ricavi della sua prima collezione Elsa compra una casa. Poco dopo, nel 1928, l’ex marito muore in una rissa fuori da un bar di New York. Gli sparano allo stomaco. Triste a dirsi, ma per Elsa è un sollievo non dover più lottare per la custodia della figlia.
Avendo la testa meno impegnata sulla sopravvivenza sua e di Gogo grazie a un invidiabile conto in banca, Elsa trova il coraggio di mettere alla prova la sua immaginazione, cosa che l’abbigliamento sportivo e casual non permette più di tanto. La nuova collezione Schiaparelli supera lo sport. Al posto di Pour le Sport, la maison usa Pour la Ville, pour le soir (per la città, per la sera) come nuovo slogan. Il target del pubblico è nettamente diverso dal precedente. Elsa vuole ampliare il suo lavoro, dimostrare ciò che è capace di fare.
La nuova collezione esce nel 1929 ed è un successo immenso, ma Elsa non si gode a lungo il proprio exploit perché presto la maison deve affrontare le conseguenze del crollo della borsa di New York e la Grande Depressione. Per fortuna in Europa la Depressione arriva dopo e dà un po’ di tempo agli imprenditori per tentare di organizzarsi al meglio. Elsa cerca di ovviare al dissanguamento pecuniario monopolizzando le esportazioni e prendendo come clientela di riferimento la classe media e quella alta. Ciò le permette di non vendere quote aziendali e mantenere il controllo totale dell’azienda anche da un punto di vista economico e non solo creativo. Elsa è una delle pochissime nel mondo della moda a possedere tutte le quote della propria azienda.
Durante gli Anni Trenta, i suoi design bizzarri e geometrici vengono presi come punto di riferimento perché danno colore a un periodo buio della storia mondiale. I motivi che disegna sugli abiti sono una possibilità di evasione dalla realtà grigia del disagio economico e dei primi totalitarismi. La sua personalità spumeggiante le permette poi di intessere relazioni durature e soprattutto di fidelizzare i clienti. Anche i suoi dipendenti le vogliono molto bene. Elsa tiene in affitto perenne due posti letto in ospedale riservati a tutti i dipendenti, anche quelli in pensione. Una sorta di assicurazione sanitaria, una forma di welfare aziendale che conferma la sua generosità ma soprattutto l’attenzione per i dettagli. I suoi professionisti lavorano di loro spontanea volontà in esclusiva: significa che Elsa può vantare dei designers che disegnano solo per Schiaparelli e rifiutano lavori per altre famose maisons. Significa anche che Schiaparelli è il massimo a cui un designer può aspirare. Riesce a creare un ambiente lavorativo che esalta le qualità del singolo e che lo mette nelle migliori condizioni per svolgere il proprio lavoro.
Elsa non lascia indietro nessuno, men che meno i suoi amici. A lei gli affari vanno molto bene, ma il suo mentore Poiret non può dire lo stesso. Per aiutarlo, Elsa compra dei quadri che aveva dipinto e ne organizza un’esibizione a Parigi. Dopodiché va spesso a trovarlo a cena indossando religiosamente i vestiti che lui ha disegnato.
Durante gli anni Trenta, non si sa esattamente quando, anche la vita sentimentale di Elsa prende una bella piega, anche se è quantomeno bizzarra come le sue creazioni. Si innamora di due fratelli, Allan e Henry Horn. Allan è un imprenditore in campo immobiliare molto più grande di Elsa, mentre Henry ha solo un anno in più di lei. Intraprende due relazioni parallele, una con Allan e una con Henry. Nessuno però si lamenta. Gogo nutre un grande affetto soprattutto per Henry, che considera un vero e proprio padre. Elsa in realtà non crede più nelle relazioni a lungo termine, sia per il poco amore ricevuto da piccola sia per il matrimonio tragico con William. Le due relazioni però vanno avanti per molto tempo forse proprio perché non si prendono troppo sul serio.
Allan le permette di aprire un negozio a Londra in un edificio che aveva acquistato approfittando del crollo della borsa. In questo modo nel 1934 la maison si amplia ancora di più. Elsa ha sotto di lei 400 dipendenti.
A metà degli anni Trenta, Elsa inventa anche il prêt-à-porter. Fino a quel momento lo shopping non era quello che conosciamo noi oggi. Non si entrava in negozio, si sceglieva un capo, si pagava e si usciva. All’epoca si andava dal sarto, dalla modista o dalla stilista, si sceglieva un modello che poi veniva confezionato e modificato per adattarlo al corpo della cliente. Elsa invece permette ai clienti di scegliere un capo e portarselo subito a casa, prevedendo persino delle piccole alterazioni realizzate dalle sarte sul momento. Chiaramente è un successo.
La fama e i soldi ottenuti le permettono una libertà creativa che prima non aveva. Collabora con artisti di tutti i campi, non solo designer di moda. La scrittrice Elsa Triolet disegna per lei la famosa collana Aspirin, un doppio girocollo blu realizzato in pasta di vetro. Si chiama Aspirin perché la disposizione delle perline ricorda i tablet dell’aspirina. Salvador Dalì invece disegna con lei un portacipria a forma di quadrante del telefono fisso e dei disegni per promuovere le sue collezioni.
A proposito di collezioni, è lei a inventare le collezioni a tema, cioè un corpus di lavori coerente ispirato a un’idea o a un mondo. La più famosa è sicuramente quella ispirata al circo. Il pezzo più famoso della collezione è una giacca rosa con bottoni a forma di trapezzista. Non solo gli abiti sono scenografici: anche la presentazione delle collezioni è uno spettacolo coreografato, un debutto teatrale a cui vengono invitate le star del tempo, da Marlene Dietrich a Lauren Bacall. Elsa pensa a ogni dettaglio perché, come dice lei:
“Un abito non è solo stoffa: un abito è un pensiero.”
Le creazioni di Elsa rimangono impresse, come nel caso del cosiddetto vestito aragosta, un abito bianco con un’enorme aragosta disegnata sulla gonna. È in questo tipo di creazioni che si vede l’influenza che il surrealismo esercita su Elsa. Realizza dei cappelli in feltro che sono delle vere e proprie sculture, dei guanti neri con le unghie rosse, altri con cicatrici che non sono altro che cerniere. In questo periodo, tra l’altro, lavora molto con Man Ray, che fotografa sia lei che alcuni pezzi delle sue collezioni per le più importanti riviste di moda.
Elsa realizza anche un tessuto che ricorda la carta, ispirato dalla tecnica papier collé usata spesso dai cubisti nell’elaborazione dei loro quadri. Consiste nell’incollare pezzi di carta diversi per dare illusione di avere diverse texture sulla tela. Elsa fa la stessa cosa con gli abiti. Stampa sui tessuti gli articoli di giornale usciti sulla maison e alcuni disegni realizzati dal fotografo di moda Cecil Beaton.
Elsa è audace non solo con i design ma anche con i colori. Nel 1937 lancia il profumo Shocking insieme ad abiti con un colore creato apposta da lei: il rosa shocking che diventerà noto come Rosa Schiaparelli. Elsa scrive:
“Ho dato al rosa la forza del rosso ed è diventato un rosa irreale”.
Il più famoso pezzo di questo colore è la cappa Phoebus con un sole realizzato con fili dorati intrecciati sulla schiena.
In tutto ciò però Elsa non dimentica la comodità. I suoi vestiti sono morbidi, spesso hanno grandi tasche e anche delle culotte per andare in bicicletta.
Nel 1938 Gogo torna a vivere con lei dopo il collegio svizzero e le due si trasferiscono vicino agli Champs-Elysees in una casa enorme il cui salotto diventa un punto di riferimento per gli intellettuali e i benestanti parigini e non. Le sue feste sono leggendarie e tutti fanno a gara per ricevere un invito. Durante una festa Coco Chanel dà fuoco a Elsa nel corso di una gara di costumi. La spengono con della soda ed Elsa non se la prende. Coco però fa una figura barbina, l’ennesima a dire la verità. Coco è molto gelosa di Elsa perché durante gli Anni Trenta Schiaparelli è più popolare di Chanel. Anche se la maison di Chanel non perde la popolarità che aveva acquistato negli anni, Coco non sopporta Elsa e viceversa. Elsa la chiama “cappellaia” perché la maison Chanel aveva iniziato confezionando cappelli. Coco invece la prende in giro perché non aveva ricevuto un’educazione sartoriale e la chiama “l’artista italiana che fa vestiti”. Hanno due concezioni della moda molto differenti.
Poco dopo l’incidente infuocato inizia la Seconda Guerra Mondiale. Già nel 1922 dopo la Marcia su Roma Elsa aveva espresso il suo disprezzo per Mussolini e il fascismo. È politicamente molto attiva, ovviamente radicale e parla liberamente del suo disprezzo per la situazione politica italiana. È poi membro del gruppo Solidaritè International Anti-Fasciste.
A causa della guerra Elsa chiude il ramo aziendale a Londra e ritorna a tempo pieno a Parigi, dove accoglie rifugiati belgi a casa sua. Presto casa sua diventa un punto di riferimento per soldati alleati e civili volontari. Elsa disegna anche delle uniformi per la Salvation Army che gli fornisce gratuitamente. Mette anche a disposizione la cantina del negozio come rifugio antiaereo. La maison cerca di sopravvivere, ma deve tagliare manodopera e gli stipendi perché le vendite si dimezzano.
Elsa e i suoi dipendenti decidono però di continuare perché sono convinti che la moda possa migliorare la morale, mostrare al mondo qualcosa di bello di cui durante guerra si sente la mancanza. Sembra stupido, da illusi, fare questo tipo di scelta: una resistenza creativa, diversa. Tuttavia, la maison Schiaparelli la sente imperativa e imprescindibile. Secondo Elsa in tempi di crisi la moda deve essere oltraggiosa, porre domande, denunciare. È curioso che un’artista che lavora così tanto su mondi paralleli, irreali, onirici sia in realtà convinta che il suo lavoro sia intrecciato con la vita reale e quotidiana. Significa che per lei l’arte non è un’evasione perpetua, ma un metodo per rielaborare il reale e restituire un’idea, un ragionamento, una storia che è intimamente dipendente dal reale stesso.
Sicuramente il collegamento con il mercato statunitense aiuta gli affari durante la guerra e permette ad Elsa di non chiudere i battenti, ma anche una serie di accorgimenti di vero e proprio design come sostituire i bottoni con le più economiche cerniere.
Nel 1940 gli Stati Uniti richiamano in patria tutti i cittadini statunitensi residenti in Europa. Tra di loro c’è anche Gogo, che ha il passaporto statunitense essendo nata a New York. Gogo salpa da Genova e sulla nave incontra Robert Berenson, con cui si fidanza due settimane dopo la fine del viaggio.
Tra madre e figlia purtroppo non corre buon sangue. Gogo risente dell’assenza materna durante l’infanzia, non apprezza i design della maison e ha una natura schiva e timida. Non riesce ad amare la notorietà e la vita pubblica che Elsa non ha problemi ad accettare. Le due rimangono cordiali in pubblico ed Elsa cerca di ricucire con la figlia secondo i metodi che conosce. Confeziona una collezione per bambini con il suo nome, ma Gogo la detesta e non coglie il tentativo materno di omaggiarla e dimostrarle il proprio bene. Non la invita nemmeno al matrimonio con Robert, cosa per cui Elsa soffre parecchio.
Presto la guerra rende impossibile proseguire il lavoro. Si trasferisce a Biarritz sulla costa occidentale della Francia per fuggire dai bombardamenti e lascia casa sua agli alleati come rifugio.
Quando riceve la notizia dell’entrata in guerra di Mussolini al fianco della Germania, Elsa si siede per terra e piange inconsolabile. Si vergogna di essere italiana e che la sua patria attacchi il paese in cui ha scelto di vivere. Quando si rialza decide di usare la moda come propaganda contro il fascismo. Vuole convincere l’opinione pubblica statunitense a schierarsi insieme agli alleati e a scendere in guerra. Inizia una serie di seminari nei club, nei grandi magazzini e nelle università statunitensi intitolati “I vestiti fanno la donna”. Gira tutto il paese: da New York al Grand Canyon. Nel mentre disegna una nuova collezione per il mercato americano. Vende le repliche dei suoi design durante i seminari a solo un dollaro per contribuire al fondo per i lavoratori della moda europei rimasti senza lavoro. Organizza anche un’esibizione di dipinti di bambini francesi che vengono venduti e il cui ricavato viene devoluto alla Croce Rossa Internazionale.
Nell’agosto 1940 i tedeschi prendono Parigi e impongono agli stilisti di alta moda di chiudere oppure di spostarsi a Berlino o a Vienna. Tutti i design poi devono essere approvati dai nazisti ed essere pensati per le donne tedesche. Dopo un po’ di proteste i nazisti acconsentono a non costringere tutte le maison a traslocare, ma in ogni caso iniziano a fregare professionisti del settore riducendo quindi la manodopera disponibile in Francia. I lavoratori del mondo della moda omosessuali, ebrei, o che hanno qualsiasi altro attributo di natura che Hitler non gradisce - probabilmente perché lo è lui stesso, come tutti gli psicopatici intellettualmente limitati - vengono spediti nei campi di concentramento dove devono confezionare vestiti per mogli, amanti e fidanzate dei nazisti. Lo stesso destino tocca al primo sarto di Schiaparelli. Elsa è all’estero quando i nazisti lo portano via, ma dà istruzioni di fare tutto il possibile per riportarlo a Parigi. Ci riesce facendo presente che è indispensabile per la maison rimanere aperta dato che è la più famosa casa di moda in Francia e all’estero. Hitler non avrebbe fatto il suo stesso interesse a metterla in eccessiva difficoltà. L’attenzione verso la propaganda che nutre il nazismo permette quindi a Elsa di salvare il suo sarto e di riportarlo sano e salvo a Parigi.
Nel 1941 Elsa torna nella capitale francese con un carico di vitamine e dei medicinali per i civili nelle zone non occupate della Francia. I suoi contatti statunitensi le suggeriscono però di andarsene velocemente da Parigi perché è nel mirino di Mussolini e di Hitler per le sue attività antifasciste svolte all’estero. Affida i suoi gioielli e gli oggetti di valore al suo amico Cartier e la casa all’ambasciata brasiliana, che rimane neutrale. Sceglie delle persone fidate per mandare avanti la maison e scappa.
Qui però sorge un problema. Elsa conosce tutti. Sia da una parte che dall’altra. Questo causa sospetti persino tra gli alleati. I tedeschi le congelano i conti, ma anche gli alleati non vedono bene le amicizie naziste, che Elsa intrattiene banalmente per continuare a dare lavoro ai suoi dipendenti. Il suo ex avvocato viene accusato di spionaggio, cosa che non aiuta la sua posizione agli occhi dell’opinione pubblica. Certamente non aiuta nemmeno il fatto che lei sia italiana, tant’è che l’FBI apre un fascicolo su di lei.
Elsa viaggia un po’ per il Sud America per togliersi dai pasticci, peccato che questo non faccia altro che aumentare i sospetti anche se i suoi programmi filantropici non vengono sospesi e collabora anche con Picasso e Peggy Guggenheim per garantire la sopravvivenza a più francesi possibile. Viene persino invitata alla Casa Bianca, ma l’investigazione su di lei va avanti. Vive in esilio dalle sue patrie, indagata da entrambe e anche da quella che la ospita temporaneamente, ovvero gli Stati Uniti.
A ragion veduta, Elsa si intristisce in questo periodo e non riesce a lavorare. Per fortuna l’FBI conclude che Elsa sia fermamente contro l’Asse di Berlino, una convinta antifascista che ha intrattenuto contatti con i gerarchi nazisti solamente per non licenziare i suoi dipendenti e aiutare più persone possibile dall’interno del fronte nemico. Elsa rimane negli Stati Uniti fino al 1945 pur senza lavorare. Non disegna nemmeno un vestito.
Dopo la guerra la maison non riesce ad avere lo stesso successo, ma Elsa continua la sua beneficenza per aiutare il popolo francese a rimettersi in piedi. Ripara i vestiti e li spedisce nel nord della Francia, dove i cittadini sono stati più colpiti dalla furia nazista e dal tentativo degli alleati di liberare il paese.
Gli stilisti francesi devono ricostruire da zero tutta la filiera della moda, dalle infrastrutture per lavorare le materie prime alla distribuzione. Elsa non riesce ad attrarre quanto altri designer, soprattutto Christian Dior. È interessante perché Dior, oltre a essere un conservatore che ritiene la donna non più di un soprammobile domestico, aveva lavorato anche per le mogli dei nazisti durante l’occupazione. Certo, anche Dior l’aveva fatto per non essere costretto a chiudere, ma Elsa che è stata solo sospettata e poi scagionata da ogni accusa deve riprendere in mano la sua reputazione e subisce un calo di popolarità.
I vestiti di Dior poi ricalcano la sua idea posticcia di donna. È una donna conservatrice che non lavora. Eppure hanno presa sulle donne francesi mentre la vena surrealista di Elsa e i suoi design pensati per donne indipendenti ed eclettiche non hanno più lo stesso successo. I clienti sono meno, ma i costi si alzano.
Nel 1947 Elsa assume Givency, che presto si accorge che la maison sta sanguinando finanziariamente. Lo stesso anno Gogo dà alla luce la sua primogenita e il rapporto con sua madre si riappacifica. Quando si diventa madri si comprende che molte mancanze della propria madre in realtà erano solo dei modi per dire che ci vuole bene. Si può anche andare in terapia per capirlo, non c’è bisogno di figliare.
Nel 1954 Elsa presenta la sua ultima collezione prima di chiudere definitivamente la maison. Un po’ di consolazione le arriva dalla pubblica gogna che subisce Coco Chanel, esiliata fino al 1954 per aver collaborato con i nazisti. E anche qui potremmo ritenere che Coco avesse collaborato con i nazisti per permettere alla sua maison di sopravvivere. Peccato che Coco avesse anche sfruttato le leggi contro gli ebrei per prendere il controllo della branca della maison che realizzava i profumi e che era controllata da alcuni imprenditori ebrei. Diciamo che era stata una collaborazione più attiva. Coco Chanel quindi era una nazista? Non si sa. Qualcuno sostiene di sì, altri no. Io il profumo Chanel Noir continuo a indossarlo, anche perché in realtà l’ha creato Jacques Polge. Pur senza la sua casa di moda Elsa ha una reputazione che le permette di vivere serena, cosa che Chanel non può dire.
Elsa non perde la propria generosità nemmeno dopo la guerra. Aiuta i giovani designer, primo fra tutti Givency, indossando in continuazione i loro abiti. Decide di passare i suoi ultimi anni godendosi la vecchiaia. Compra una casa ad Hammamet, in Tunisia. Riprende i rapporti con le nipoti, che non hanno un grande rapporto con la loro mamma Gogo. Gogo le aveva mandate in collegio in Europa e gli permetteva di visitarla solo una volta ogni tre anni. Peggio di quello che aveva fatto Elsa con lei, che per di più era in parte giustificata dal fatto che dovesse lavorare instancabilmente per pagarle le cure. Le nipoti non si legano molto alla nonna, ma le vogliono bene soprattutto perché è alquanto permissiva.
Elsa muore nel 1972 a 82 anni. Sua nipote Marissa è accanto a lei. Appena prima di morire, Elsa le racconta con un filo di voce di Pino, il suo primo amore, il ragazzo napoletano che i suoi genitori avevano cacciato perché troppo povero per sposare la figlia. A un certo punto guarda nel vuoto: “Pino sei tu?” Dopo questa domanda, Elsa esala il suo ultimo respiro.
Consigli di lettura (Amazon affiliate links)
Shocking life https://amzn.to/3Mskzml
Vogue. Elsa Schiaparelli. Ediz. a colori https://amzn.to/3X6PNEI
Coco Chanel e Elsa Schiaparelli https://amzn.to/3XbBheV