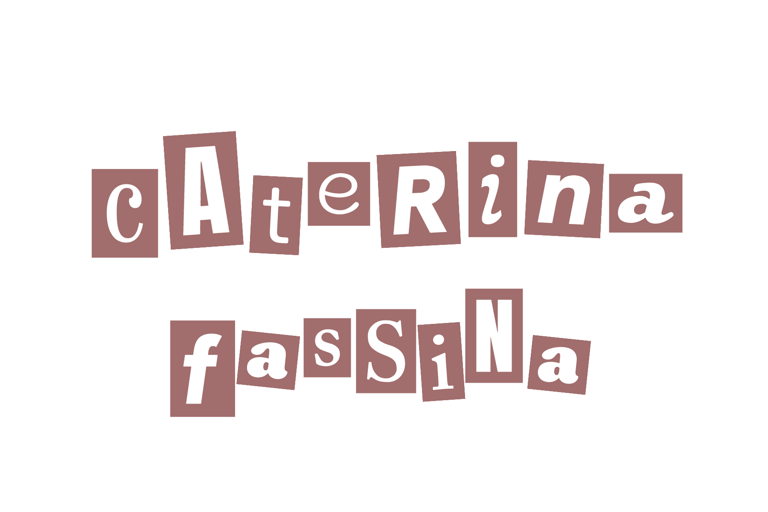Elisabeth Vigée Le Brun: l'ultima ritrattista
Elisabeth Vigèe Le Brun ha reso immortale le donne dell'Ancien Régime, prodigio precoce e donna borghese che si interfaccia con la monarchia francese appena prima che la Rivoluzione cambiasse l'assetto della nazione.
Caterina Fassina
9/24/202414 min read
Tutti abbiamo studiato il Settecento francese sui libri di storia. Abbiamo sentito parlare dell’Illuminismo, una corrente culturale che presto diventa politica e invade non solo la Francia, ma tutta Europa. La borghesia benestante comincia a sostituire il potere dell’aristocrazia e i circoli intellettuali di Parigi ribaltano le sorti della Francia intera. Voltaire, Diderot, Rousseau, pubblicano i propri trattati filosofici proprio nella prima parte del Settecento. Filo che collega i loro pensieri è il dominio della Ragione su ogni aspetto della realtà: dalla Natura alla vita umana. La Ragione è il principio regolatore del mondo. Per gli Illuministi la ricerca scientifica assume un’importanza cruciale per il progresso. Le cosiddette superstizioni, la religione, le tradizioni, i sentimenti, non sono altro che tentativi dell’uomo di spiegarsi fenomeni che la scienza non ha ancora compreso.
La politica francese all’inizio del Settecento è ancora in mano all’aristocrazia, un’aristocrazia che sperpera parecchio denaro. Il re è oggetto d’investitura divina, significa che viene scelto di Dio, ed è quindi anch’esso creatura divina a metà fra Terra e Cielo. Aristocrazia e religione sono inscindibili. Gli Illuministi propongono invece la separazione tra Stato laico e Chiesa. Vogliono trasformare la Francia in una democrazia che consegni il potere in mano al popolo - ovviamente per popolo s’intende uomini borghesi istruiti, non certo gli analfabeti, i poveri o le donne. La Chiesa Cattolica, presente in Francia quanto in Italia, e la famiglia reale sono ritenute le fautrici di un clima politico che vive di ingiustizie sociali e sono accusate di ottenebrare le menti del popolo per mantenere la propria egemonia culturale ed economica. Presto tali rivendicazioni escono dai salotti degli intellettuali per invadere le piazze parigine e diventare un vero e proprio movimento di popolo.
In mezzo a questo secolo di profondo rinnovamento sociale nasce Elizabeth-Louise Vigeé Le Brun. Viene al mondo a Parigi nel 1755, figlia di un pastellista ritrattista e di una parrucchiera nota nel circolo degli artisti parigini per il suo fascino. All’epoca è prassi che i figli delle famiglie di media e alta borghesia che risiedono in città vengano mandati a vivere in campagna da una famiglia adottiva, che solitamente è quella della balia. È quindi normale che i bambini di famiglie benestanti passino l’infanzia lontani dalla famiglia biologica per permettere ai genitori di concentrarsi sul lavoro e di dedicarsi alla vita in società aumentando il proprio prestigio. Compiuti i sei anni, le famiglie biologiche riprendono i bambini con sé perché ormai in età scolare. Questo è anche il destino di Elisabeth, che vive insieme alla famiglia della sua balia fino ai sei anni, quando viene prelevata da un padre che non ha mai visto o frequentato per tornare a Parigi. La responsabilità genitoriale all’epoca consiste nel garantire una buona istruzione e prestigio piuttosto che nella manifestazione dell’amore tramite gesti d’affetto. Elisabeth, infatti, torna in città per essere subito affidata al convento della Trinità, un collegio femminile che prepara le giovani parigine a diventare buone socialites e mogli.
Nonostante l’implicita diffidenza per un ambiente famigliare che non riconosce come suo, Elisabeth lega presto con il padre grazie al suo precoce talento nel disegno. Una volta conclusi gli studi in collegio, all’età di dodici anni viene mandata dal padre a bottega presso un amico di famiglia, il pittore Pierre Davesne. Purtroppo il legame con il padre si spezza presto. Il papà di Elisabeth muore nel 1767. La madre si risposa con un uomo che né Elisabeth né i suoi fratelli accetteranno mai. Non che il patrigno facesse il possibile per farsi apprezzare. Elisabeth scrive nei suoi diari che l’uomo s’impossessa del guardaroba del padre indossando i suoi vestiti e le requisisce i primi soldi che guadagna come ritrattista.
Per ovviare alla pesante situazione famigliare, la madre la incoraggia a passare il proprio tempo lontana da casa. Elisabeth sceglie le gallerie d’arte parigine, dove trascorre le giornate esercitandosi e copiando grandi pittori: Van Dyke, Rubens, Rembrandt. Nel pieno della sua adolescenza è già una pittrice professionista e si fa riconoscere a Parigi per il suo abbigliamento inusuale. Non sopportando la moda femminile Rococò piena di fronzoli e orpelli, Elisabeth indossa delle bluse bianche di mussola leggera abbinate a gonne lunghe altrettanto bianche che imbellisce con un drappo colorato che si avvolge a mo’ di cintura attorno alla vita. Si rifiuta persino di indossare le parrucche grige eccessivamente elaborate che andavano di moda per portare invece i capelli al naturale.
Il suo stile susciterà inizialmente scandalo, ma viene presto emulato dalle donne dell’alta società francese. Elisabeth è quella che oggi definiremmo una it girl, una giovane ragazza a cui le cronache scandagliano scelte di vita e di stile. A soli quindici anni diventa la protetta di Madame de Verdun e della Duchessa di Chartres, due socialites che la introducono nei giusti circoli dell’alta nobiltà di Parigi permettendole di intessere i primi legami con clienti prestigiose.
Anche molti uomini iniziano a prenotare sedute nel suo studio per essere ritratti, ma si distraggono spesso guardando Elisabeth, che ha ereditato il fascino della madre, condito però con la ribellione giovanile che risulta spesso molto attraente agli occhi degli uomini in crisi di mezza età. Elisabeth allora, per evitare il fastidio di essere fissata mentre lavora, inventa il ritratto con lo sguardo perso in lontananza. Avete presente quelle foto in cui ci si chiede dove il soggetto stia guardando? Gli sarà apparsa la Madonna? Quelle dove il soggetto indossa quello sguardo truce o solenne, pieno di speranza per l’avvenire. Si vede spesso anche sui cartelloni delle campagne elettorali di oggi. Ecco, l’origine di questa posa è il tentativo di Elisabeth di non venire disturbata mentre lavora. Solo le donne le rappresenta con lo sguardo rivolto verso di lei.
Ed è proprio per i suoi effetti di chiaro-scuro sui volti delle nobildonne parigine che Elisabeth diventa famosa. Per esercitarsi, nel 1782 realizza un autoritratto con un cappello di paglia a tesa larga pieno di decorazioni. Il cappello genera un’ombra appena accennata sul volto, un volto dai lineamenti dolci che possiede un colorito naturale e non celato dietro un muro di cipria. Elisabeth tiene in mano la sua tavolozza piena di colori e la avvolge uno scialle nero. Guarda lo spettatore con le labbra morbide e leggermente aperte. Le donne di Parigi s’innamorano di questa rappresentazione diretta e audace. È un autoritratto in cui Elisabeth controlla la propria rappresentazione. Solitamente erano gli uomini, pittori o romanzieri, a decidere come rappresentare le donne. Elisabeth invece si rappresenta nella sua bellezza e mettendo in primo piano cosa la caratterizza di più ovvero l’amore per la pittura. È un quadro molto erotico perché simbolo di emancipazione femminile. Per questo motivo le donne parigine le commissionano ritratti che le rappresentino con gli stessi accessori e le medesime caratteristiche estetiche.
Ora facciamo un passo indietro per capire come la situazione sociopolitica stesse evolvendo in Francia durante la seconda metà del Settecento. Nel 1770 Maria Antonietta, figlia di Maria Teresa d’Asburgo, arriva in Francia per sposare Luigi XVI. Maria Antonietta viene scelta per suggellare l’alleanza tra Austria e Francia contro la Prussia e l’Inghilterra. Quando raggiunge Parigi, Maria Antonietta ha solo quindici anni. Probabilmente la giovane età le suggerisce di vivere nell’opulenza, atteggiamento che viene aspramente criticato da un’opinione pubblica francese sempre più ostile all’aristocrazia e ormai convinta degli ideali illuministi. Per di più il matrimonio con Luigi XVI, che ha solo sedici anni, ha un inizio tormentato e subisce varie frustrazioni esterne, oltre che per il clima politico, anche perché la coppia pare avere difficoltà di concepimento. La madre Maria Teresa d’Asburgo spedisce il figlio Giuseppe, fratello di Maria Antonietta, a Versailles per capire se ci fosse qualche problema in camera da letto. Giuseppe capisce presto che Maria Antonietta e Luigi non hanno ancora consumato il matrimonio a causa di una profonda ignoranza e inesperienza nei confronti del sesso, oltre a un fondamentale disinteresse nella questione. Si pretende che questi due adolescenti che non sanno nemmeno come concepire un erede controllino una delle nazioni più importanti d’Europa. Giuseppe dà dei consigli tecnici alla sorella e il matrimonio viene consumato nel 1777. Finalmente Maria Antonietta rimane incinta e partorisce una femmina. Come da etichetta al parto assiste tutta la corte. Il concetto di privacy alla corte francese non esiste.
Il comportamento frivolo di Maria Antonietta continua però a creare inimicizie presso molte famiglie nobili francesi, che diffondono gossip fasulli sul suo conto, minando la già pessima reputazione di cui la sovrana gode presso il popolo.
Durante questi drammi aristocratici la nostra Elisabeth si sposa con Jean-Baptiste Pierre, un mercante d’arte. Il sodalizio professionale con Jean gioca un ruolo cruciale nella carriera di Elisabeth. Hanno un rapporto molto paritario. Lui lavora come suo agente e la aiuta a diventare una delle ritrattiste più pagate della Francia. I due hanno una figlia, Julie. Elisabeth si autoritrae con lei in un quadro del 1786 che dà scandalo perché Elisabeth si rappresenta sorridente e con la bocca semi-aperta, contravvenendo alle regole dello stoicismo neoclassico. È un dipinto in cui un sentimento materno tenero verso la bambina traspare e colpisce direttamente lo spettatore, ma questo all’epoca è considerato un difetto. Ricordiamoci che Elisabeth non aveva visto i suoi genitori fino ai sei anni: ritrarsi con la figlia piccola in braccio è una rivoluzione dei rapporti famigliari.
Una delle sfumature più interessanti della produzione artistica di Elisabeth è proprio l’attenzione verso la maternità e l’infanzia. Il suo autoritratto con Julie causa sì scandalo nel mondo dell’accademia, ma anche un impellente desiderio di emulazione tra le donne nobili del tempo. Elisabeth ha di fatto sconvolto l’austerità e la distanza con cui venivano ritratti i figli e le madri. È peculiare che la tenerezza e la rivalutazione del ruolo materno siano state introdotte nel mondo dell’arte da una madre lavoratrice borghese. Forse sono proprio le donne che lavorano ad avere piena consapevolezza dell’importanza del tempo e delle attenzioni verso i figli.
La vita della regina Maria Antonietta s’intreccia con quella di Elisabeth nel 1778 grazie alla Duchessa di Chartres. Maria Teresa d’Asburgo aveva consigliato caldamente alla figlia di assumere un pittore ufficiale a scopi propagandistici per migliorare la pessima reputazione della famiglia reale. Così Maria Antonietta si affida proprio a Elisabeth e tra le due si instaura un rapporto personale stretto, un’amicizia genuina.
L’entrata di Elisabeth a corte e la sua collaborazione con la regina generano però non pochi pettegolezzi sul suo conto. Le malelingue riportano di diverse relazioni extra-coniugali, orge, libertinaggio. Sono ovviamente gossip che intendono colpire la regina piuttosto che Elisabeth, anche se probabilmente in questo periodo ha in effetti una relazione extra-coniugale con un conte.
Elisabeth realizza molti ritratti di Maria Antonietta. Nel primo la regina è imbellettata nei vestiti di corte e ancora conserva i tratti del volto caratteristici degli Asburgo: labbro inferiore carnoso, occhi grandi e sporgenti, una mascella poco pronunciata. Nelle opere successive queste caratteristiche vengono smussate il più possibile per rendere Maria Antonietta più vicina ai canoni estetici francesi. Di fatto Elisabeth funziona come un software per ritocchi e cerca di esaltare i lati migliori dei suoi clienti. Elisabeth però rimane molto colpita dalla carnagione traslucida di Maria Antonietta e ammette di non riuscire a renderle giustizia con i suoi strumenti. Maria Antonietta in cambio l’aiuta a diventare membro dell’Accademia Regale Di Pittura e Scultura, che escludeva chiunque avesse legami con il mondo della commercializzazione dell’arte. Essendo all’epoca le donne identificate con il lavoro del marito ed essendo Elisabeth sposata con un mercante d’arte, la sua iscrizione era sempre stata rifiutata. Maria Antonietta interviene a suo favore e finalmente Elisabeth viene riconosciuta per la pittrice abilissima che è.
Nel 1783 espone per la prima volta al Salon di Parigi, una mostra periodica di quella che veniva selezionata come arte ufficiale francese dai professori dell’Accademia di Belle Arti di Parigi. Al solito Elisabeth darà scandalo con un ritratto della regina abbigliata con un abito di mussola leggera - tessuto usato solo per la lingerie - e un cappello di paglia a tesa larga. Il quadro viene presto sostituito con un ritratto della regina nella stessa posizione, ma questa volta mentre indossa un vestito di seta francese.
L’ultimo ritratto che Elisabeth realizza della regina è una rappresentazione del suo lato materno. Maria Antonietta con i tre figli piccoli attorno. Questo dipinto, così come gli altri, viene commissionato per rimediare alla reputazione della regina sperperatrice, ma c’è ormai poco da fare e la Francia si avvia verso la Rivoluzione.
Il 14 luglio del 1789 la fortezza della Bastiglia viene presa d’assalto dai rivoluzionari illuministi insofferenti a causa della cattiva gestione dello Stato e per la diffusa povertà. Aizzati ideologicamente dagli intellettuali borghesi, i rivoluzionari decidono di abolire i diritti feudali e mettere così fine all’Ancien Régime e alla monarchia assoluta.
A ottobre, nonostante i tentativi di mediazione di Luigi XVI, una folla di donne francesi marcia su Versailles, entra nella reggia e costringe la famiglia reale a trasferirsi al Palazzo delle Tuileries, che diventa per loro una gabbia d’oro. La Francia si trasforma in una monarchia costituzionale. Il potere legislativo non appartiene più a Luigi XVI ma all’Assemblea nazionale costituente, che avvia varie riforme.
Luigi XVI e Maria Antonietta giurano ufficialmente fedeltà alla Costituzione, ma dietro le quinte tentano di raccogliere consensi presso le corti europee contro i rivoluzionari. I coniugi tentano di scappare dal Palazzo delle Tuileries verso Varennes nel 1791. Purtroppo vengono intercettati e riportati a Parigi. A questo punto è palese che i coniugi siano ostili al nuovo equilibrio politico e il popolo chiede l’abolizione della monarchia costituzionale in favore della repubblica. La Francia si radicalizza sempre di più fino all’arresto ufficiale della coppia reale, il processo e la condanna a morte eseguita nel 1793.
Durante la Rivoluzione Elisabeth lascia sia il marito che la Francia. I due continueranno a lavorare insieme ma Elisabeth scappa insieme alla figlia, temendo per la sua incolumità in quanto persona vicina alla corte. Della rivoluzione lei scriverà nelle sue memorie: “Prima della rivoluzione le donne comandavano. La rivoluzione le ha detronizzate.” Un giudizio che anticipa molta della critica femminista scritta nel ventesimo secolo contro l’Illuminismo. L’Illuminismo mette al centro del pensiero occidentale una cultura a misura d’uomo, una Ragione maschile. Le donne rimangono ai margini di questa nuova società. I danni dell’Illuminismo per le donne si trascinano fino a noi, pensiamo per esempio a un mercato del lavoro pensato per le esigenze maschili, ma anche agli algoritmi che regolano i social media, ricchi di pregiudizi di genere. Non che prima della Rivoluzione Francese le donne godessero di raffinati diritti civili o umani, ma l’Illuminismo razionalizza un pensiero che le priva persino dell’aurea di sacralità che la religione e la tradizione attribuivano alle donne grazie alla maternità. Prima dell’Illuminismo il ruolo materno delle donne era discendenza diretta della Madonna e questo garantiva alle donne un certo grado di rispetto, per quanto limitato. Con l’Illuminismo la donna rimane legata proprio per il suo ruolo materno all’interno della sfera del mistero, della Natura, dell’irrazionale. Non è un essere umano capace di grandi ragionamenti intellettuali. Questo spiega come mai nonostante la forza rinnovatrice ed egualitaria dell’Illuminismo le donne non venivano ancora ammesse nelle università. Le donne continuano quindi a essere considerate solo in quanto madri, relegate nelle quattro mura di casa a prendersi cura della prole. L’unica differenza rispetto al cattolicesimo tradizionalista è che il ruolo materno perde tutto il lustro che prima gli veniva attribuito e viene ridotto a una caratteristica biologica dentro cui le donne rimangono imprigionate.
Nel 1789 Elisabeth è in Italia. Soggiorna a Torino, Parma, Bologna, Roma, Venezia, Napoli, dove incontra Maria Carolina d’Asburgo, sorella di Maria Antonietta. Elisabeth ritrae Maria Carolina nella stessa posa della sorella, rimanendo impressionata e commossa dalla somiglianza tra le due.
A Napoli incontra anche Lady Hamilton, un’attrice londinese che aveva accalappiato in matrimonio l’ambasciatore inglese a Napoli grazie alla sua rinomata bellezza. Lady Hamilton diventa una delle modelle preferite di Elisabeth, che la ritrae nei panni della Sibilla, uno dei dipinti a cui l’artista tiene di più. Lady Hamilton viene ritratta con una tunica rossa segnata in vita con un drappo bianco che riprende il turbante che le copre i capelli. Lo sguardo è rivolto verso l’alto nonostante il soggetto sia una donna perché la Sibilla riceve visioni del futuro dagli dèi.
Dopo il soggiorno a Napoli Elisabeth tenta di tornare in Francia, ma una nuova ondata di immigrati francesi arriva a Torino a causa della politica del Terrore che stava governando la Francia rivoluzionaria. L’ex marito di Elisabeth e suo fratello vengono persino incarcerati per aver richiesto il rientro di Elisabeth a Parigi. La pittrice allora si reca in Austria per lavorare presso la corte asburgica. A Dresden ha l’occasione di vedere la Madonna di San Sisto di Raffaello di cui scrive: “Nell’arte, niente può competere con la semplicità nobile.”
Passerà qualche tempo felice finché le sue conoscenze nobiliari portano Elisabeth a vivere per sei anni in Russia, a San Pietroburgo, dove dipingerà quadri per membri della famiglia della zarina Caterina La Grande. In Russia però è costretta ad accettare il matrimonio dell’amata figlia Julie con un burocrate russo che a Elisabeth non va a genio. I rapporti tra madre e figlia s’incrinano e le due smetteranno di parlarsi a lungo.
Dopo 12 anni di esilio forzato Elisabeth decide che le acque sono abbastanza calme per tornare in Francia. Nel 1802 si stabilisce a Parigi e viene accolta con grande entusiasmo dalla stampa. Purtroppo, tuttavia, il trauma della rivoluzione e del Terrore tornano in superficie ed Elisabeth inizia a soffrire psicologicamente. Parigi le ricorda ciò che ha perso, la morte di Maria Antonietta, la fine di una città che le aveva consegnato la gloria artistica.
Decide inizialmente di allontanarsi da Parigi in una casa isolata dove potersi riconciliare con la sua patria. Successivamente decide però di ripartire per l’Inghilterra. Nonostante non amasse Londra, Elisabeth entra presto nei circoli intellettuali e nobiliari della città. Diventa amica di Re Giorgio IV, del contralto italiano Gioseppa Grassini e di molti attori che soggiornavano nella capitale inglese.
La sosta in Inghilterra dura più del previsto proprio grazie alle amicizie che Elisabeth riesce a stringere e nonostante l’inasprirsi delle relazioni tra Inghilterra e Francia.
Quando torna a Parigi, Elisabeth viene subito chiamata a corte per dipingere un ritratto di Carolina, sorella del nuovo imperatore Napoleone Bonaparte. Elisabeth accetta anche se verrà pagata solo la metà della sua tariffa usuale. Descrive il lavoro nel suo diario come “una tortura” per le vessazioni che deve subire da parte delle dame rappresentate. Ha il coraggio di dire stizzita a Carolina Bonaparte che tutte le vere principesse che ha ritratto – Carolina non aveva sangue blu – non le avevano mai causato problemi. Carolina si presenta in ritardo alle sedute, non ascolta le sue indicazioni: è più che altro una borghese viziata. Il fatto che Carolina goda di buona reputazione agli occhi dei francesi dimostra che le critiche a Maria Antonietta non provenivano da un problema reale ma piuttosto dall’insofferenza verso la monarchia assolutista.
Delusa, Elisabeth decide di lasciare Parigi e compra una casa nell’Île-de-France e torna nella capitale solo se strettamente necessario. Tuttavia nel 1814 i prussiani saccheggiano casa sua durante la guerra combattuta dalla Sesta Coalizione contro Napoleone. Per intenderci questa è la guerra che si conclude con il confino di Napoleone all’Elba. Elisabeth è costretta a scappare verso Parigi, ma è contenta che i Prussiani liberino la Francia da Napoleone e instaurino di nuovo la monarchia dei Borboni.
Nel 1819 Elisabeth purtroppo viene a sapere che la figlia Julie era rientrata a Parigi in condizioni di salute gravissime. Julie aveva divorziato e per ovviare alla povertà in cui versava si era data alla prostituzione contraendo la sifilide. Elisabeth e Julie si riconciliano appena prima della morte della figlia. Dopo questo lutto Elisabeth continuerà a cercare Julie nelle figlie di sua sorella, nutrendo con loro un rapporto strettissimo.
Gli ultimi decenni della sua vita Elisabeth li passa prevalentemente a Louvecienne, nell’Île-de-France, recandosi a Parigi solo per quattro mesi l’anno. Qui entra in contatto con una nuova generazione di giovani filosofi, scrittori e artisti, che gravitano attorno a lei mossi dalla curiosità di venire a conoscenza degli aneddoti sull’Ancien Régime. Honoré de Balzac, Chateaubriand, Victor Hugo - di cui Elisabeth non ama i romanzi - e tanti altri le fanno visita periodicamente, affascinati da una vita vissuta al massimo delle proprie potenzialità e con un'immensa passione per la propria arte.
Sopravvissuta a tutta la sua famiglia, Elisabeth muore a Louvecienne nel marzo del 1842, a 86 anni.
I suoi dipinti sono esposti oggi nei maggiori musei d’Europa. Sono perfettamente conservati perché Elisabeth era una colorista sopraffina. Gli studiosi sono concordi nel reputarla una delle più grandi tecniche del suo tempo per la maestria con cui preparava i colori per la tavolozza. Non solo i suoi colori avevano una resa eterea sulla tela, ma perdurano anche nel tempo. È stata definita l’ultima grande ritrattista europea, sicuramente l’ultima francese, l’ultima ad aver ritratto la maggior parte dell’aristocrazia europea prima dell’inizio delle rivoluzioni e degli Stati-nazione.
Cosa ci lascia Elisabeth? Una vita imperfetta sublimata dalla sua passione. È una donna che rivendica per sé una libertà che alle donne non veniva ancora concessa. È una donna che vive in fuga. Le sue amiche vengono uccise, la figlia le muore tra le braccia. Lei si ricostruisce ogni volta e non scappa mai da se stessa.
Lascia il marito ma continua a collaborare professionalmente con lui e lui si fa persino incarcerare per lei. Scappa, ma si rimette ogni volta in discussione, entrando nei circoli intellettuali di ogni luogo dove sosta.
Non si ferma nemmeno alle divisioni di classe sociale; lei è una donna borghese lavoratrice che s’interfaccia con la nobiltà. Assorbe, è curiosa, si arricchisce proprio perché fa in modo che la sua esperienza superi le teorie e la Ragione che invece il periodo storico in cui vive celebra. È proprio questo che rende i suoi ritratti diversi da tanti altri: la misura umana. I suoi ritratti rivelano una profonda conoscenza dei soggetti.
Quella di Elisabeth non è una vita convenzionale, ma è autenticamente sua. È stata piena protagonista non solo della sua vita ma del suo tempo. È sempre stata fedele a se stessa senza scorciatoie e senza sovrastrutture, felice di caricarsi sulle spalle le conseguenze di essere libera.
Testi per approfondire (Amazon Affiliate Links)
Memorie di una ritrattista https://amzn.to/4dT5sPa
Dialettica dell’Illuminismo https://amzn.to/4ed8kGq